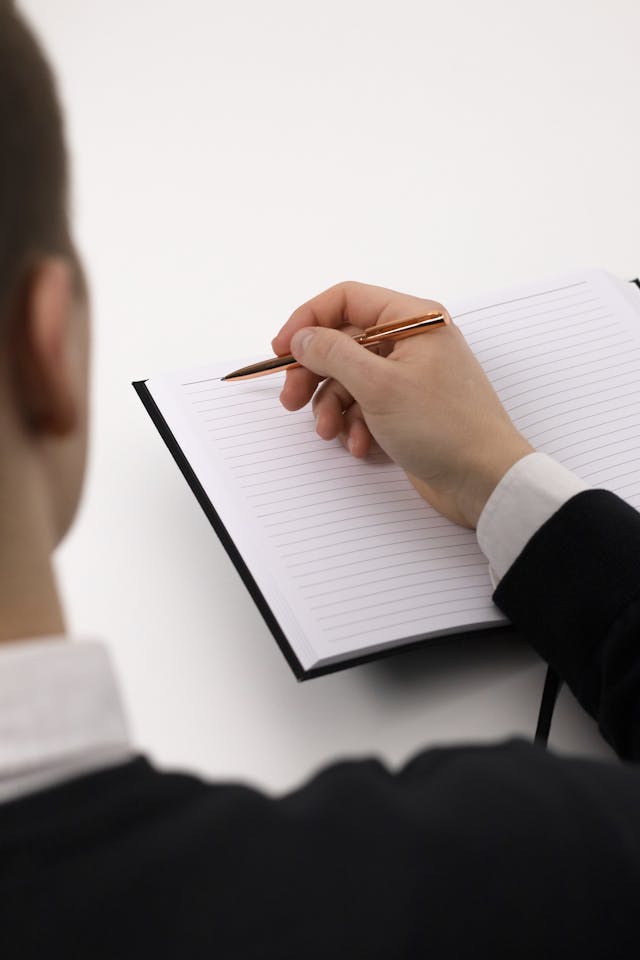L’11 dicembre 2025 si svolgerà la prova scritta dell’esame di abilitazione alla professione forense.
Per centinaia di candidati sarà il momento di dimostrare non solo la padronanza del diritto sostanziale e processuale, ma anche la capacità di redigere un atto giudiziario in modo efficace, ordinato e professionale.
Questa sarà l’ultima sessione con l’attuale impostazione semplificata. Dal 2026, infatti, l’esame scritto sarà più articolato: oltre all’atto giudiziario, sarà richiesta anche la redazione di un parere motivato, rendendo la prova più complessa e selettiva.
Per questo, è fondamentale affrontare la sessione 2025 con metodo e consapevolezza, evitando gli errori più comuni che possono compromettere la valutazione, anche in presenza di contenuti corretti.
In questo articolo analizziamo cinque criticità ricorrenti nella redazione dell’atto giudiziario, con l’obiettivo di aiutare il candidato a riconoscerle e superarle.
Scrivere bene non è solo una questione di stile: è una competenza professionale che, all’esame, può fare la differenza tra un elaborato sufficiente e uno davvero convincente.
Atto vs Parere: due strumenti, due logiche, due mentalità
Con l’introduzione del nuovo esame forense nel 2026, il candidato dovrà cimentarsi sia con la redazione di un atto giudiziario, sia con quella di un parere motivato.
Comprendere la differenza tra i due è essenziale, anche per chi affronta la sessione 2025, perché chiarisce il tipo di competenza che la commissione si aspetta.
L’atto giudiziario è un documento processuale, destinato al giudice, che rappresenta formalmente la posizione di una parte. Ha una struttura che varia in funzione della materia (civile/amministrativo o penale), un linguaggio tecnico e una funzione operativa: introdurre una domanda, articolare una difesa, formulare richieste istruttorie.
Deve rispettare le regole del processo e simulare un atto realmente depositabile.
Il parere motivato, invece, è un elaborato teorico, rivolto a un cliente o a un collega, che analizza un caso e propone una soluzione giuridica. È più discorsivo, interpretativo e libero nella forma.
Richiede capacità di analisi, sintesi e ragionamento giuridico, ma non ha vincoli procedurali.
Nel 2025, il focus resta sull’atto. Ma chi inizia a prepararsi oggi deve già iniziare a familiarizzare con entrambi gli strumenti, perché dal prossimo anno saranno entrambi oggetto di valutazione.
E soprattutto, deve imparare a distinguere la logica processuale da quella consulenziale.
Scrivere con metodo: struttura, selezione dei fatti e uso delle fonti
Chiarita la differenza tra atto e parere, entriamo ora nel vivo della trattazione: quali sono gli errori più frequenti nella redazione dell’atto giudiziario?
Il primo errore da evitare è ignorare la struttura formale dell’atto, ovviamente dopo aver scelto quale atto si vuole redigere.
Un elaborato privo di epigrafe, premessa o conclusioni ben definite, oltre a risulta disorganico, è penalizzante, in quanto potrebbe condurre a un esito negativo senza dover entrare nel merito della vicenda.
La commissione si aspetta un documento che rispecchi la logica del processo e la tecnica redazionale forense. Un atto efficace deve contenere: intestazione, identificazione delle parti, esposizione dei fatti, motivi in diritto e conclusioni: ogni sezione deve essere riconoscibile e funzionale alla comprensione del caso.
Il secondo errore riguarda l’esposizione dei fatti: troppo sintetica, confusa o eccessivamente prolissa. I fatti devono essere selezionati in base alla loro rilevanza giuridica, evitando digressioni e dettagli superflui: la narrazione deve essere chiara, cronologica e funzionale alla strategia processuale.
Il terzo errore è l’uso improprio delle citazioni normative e giurisprudenziali. Inserire articoli di legge o sentenze “a effetto” senza un reale legame con il caso non rafforza l’argomentazione e aumenta la confusione di chi legge il vostro atto.
Ogni riferimento deve essere integrato nel ragionamento, spiegato e contestualizzato. La pertinenza vale più della quantità. La tecnica redazionale, inoltre, non è da considerare un inutile orpello: è ciò che distingue un elaborato scolastico e atecnico da un atto professionale e tecnico.
Conclusioni e stile: il linguaggio che convince (o penalizza)
Il quarto errore riguarda le conclusioni: vaghe, incoerenti o incomplete. Le richieste devono essere chiare, coerenti con i fatti e con le argomentazioni giuridiche svolte.
Espressioni generiche o formule ambigue indeboliscono la strategia difensiva. Le conclusioni sono il punto fermo dell’intero elaborato e devono riflettere con precisione la tesi sostenuta.
Il quinto errore è legato allo stile. L’atto giudiziario non è un tema scolastico né un trattato accademico. Frasi troppo lunghe, toni polemici, espressioni colloquiali o burocratiche compromettono la qualità dell’elaborato.
Il linguaggio deve essere tecnico, fluido e rispettoso del contesto processuale. Scrivere bene significa comunicare con sobrietà, assertività e coerenza. Ogni parola deve avere una funzione. Ogni frase deve contribuire alla costruzione della tesi.
Il consiglio finale è semplice: rileggi sempre l’atto prima di consegnarlo. Verifica la coerenza interna, la precisione delle richieste e il tono complessivo. Il tuo stile comunica la tua professionalità. E all’esame, è anche ciò che ti distingue.
Eppure, sapere cosa evitare non sempre basta. Serve metodo, esercizio, confronto. Serve qualcuno che ti aiuti a trasformare la teoria in pratica, e la pratica in sicurezza.
Quindi, se senti il bisogno di essere guidato nella preparazione — dalla gestione della traccia alla scrittura dell’elaborato — Ripetiamo Diritto è al tuo fianco. Ti accompagniamo con simulazioni guidate e percorsi personalizzati.
Scrivere bene è la base imprescindibile per offrire una buona difesa. E all’esame, è anche la base per poterlo superare.