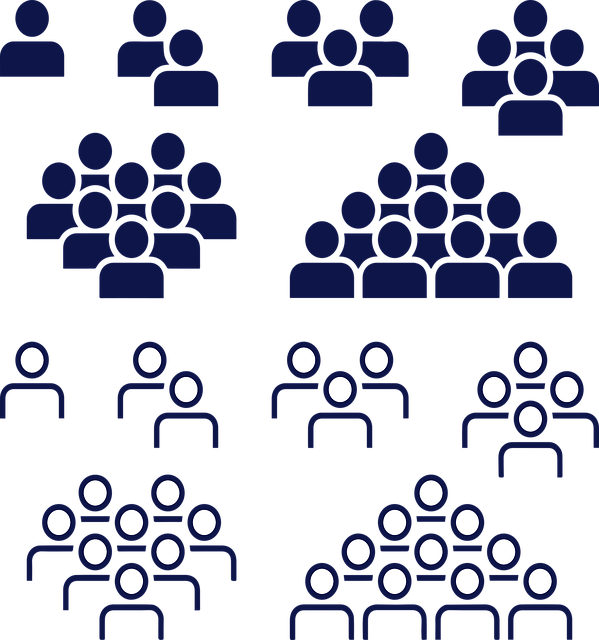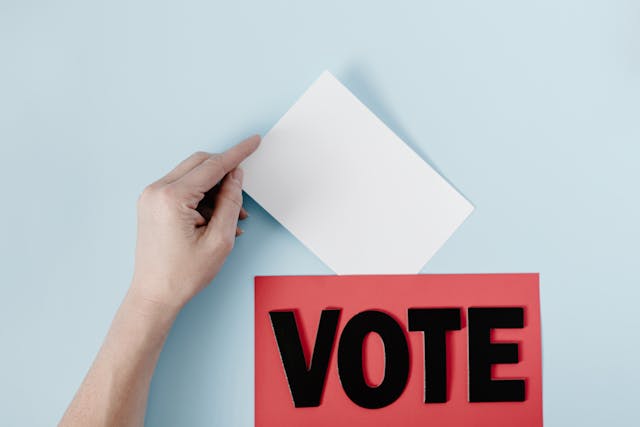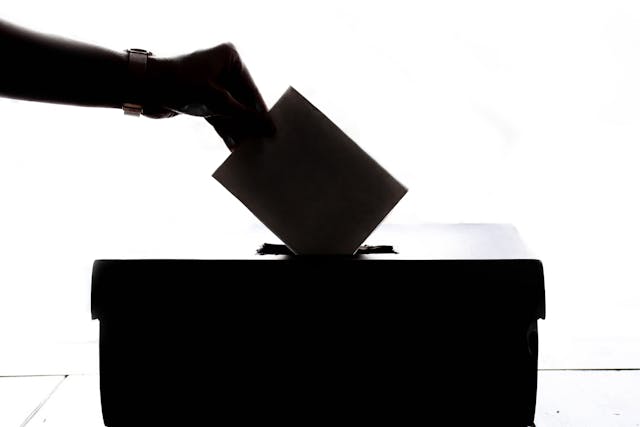Istituti di democrazia diretta
Le funzioni di stimolo, impulso e controllo nei confronti delle assemblee rappresentative vengono esercitate dal corpo elettorale attraverso istituti di democrazia diretta, previsti dalla Costituzione. Tra questi figurano la petizione, l’iniziativa legislativa popolare e alcune tipologie di referendum. È importante precisare che non tutti i referendum rientrano in questa categoria: solo alcune forme si configurano come strumenti integrativi degli ordinari meccanismi indiretti di esercizio della sovranità popolare. In questo senso, tali istituti si pongono come correttivi del sistema rappresentativo, contribuendo ad arricchirne la capacità di rispondere alle esigenze che si affermano come maggioritarie nella società.
La petizione
L’art. 50 della Costituzione riconosce a ogni cittadino il diritto di rivolgersi alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o per esporre necessità comuni. Questo diritto non è riservato ai soli elettori, ma spetta alla generalità dei cittadini. La petizione ha una funzione di stimolo nei confronti delle Camere e può riguardare sia interventi legislativi specifici sia esigenze di interesse generale.
La decisione su come procedere spetta esclusivamente all’organo parlamentare destinatario.
I regolamenti della Camera e del Senato stabiliscono che le petizioni vengano trasmesse alla Commissione parlamentare competente, che può prenderla in considerazione e deliberare in merito. Se le richieste coinvolgono l’attività del Governo, la petizione può essere trasmessa anche a quest’ultimo.
Solo il regolamento del Senato prevede che il presentatore della petizione riceva comunicazione dell’esito della medesima.
L’istituto è previsto anche a livello regionale, comunale e provinciale, ma la sua scarsa utilità ha portato alcuni consigli regionali, come quello della Toscana, a non menzionarlo più nei nuovi statuti.
L’iniziativa legislativa popolare
Numerose sono le caratteristiche che contraddistinguono l’iniziativa legislativa popolare.
I titolari del potere di proposta sono almeno 50.000 cittadini in possesso della capacità elettorale, i quali possono sollecitare l’approvazione di uno specifico provvedimento legislativo, il cui contenuto è direttamente determinato dai proponenti. Ai sensi dell’art. 71 della Costituzione, la proposta deve consistere in un progetto redatto in articoli.
La funzione dell’iniziativa è quella di stimolo: l’organo parlamentare destinatario resta libero di assumere la decisione che ritiene più opportuna.
Le Camere sono obbligate a prenderla in considerazione, ma non vincolate a pronunciarsi in merito.
Alla proposta deve essere allegata una relazione illustrativa che esponga le finalità generali e il contenuto delle singole norme.
I regolamenti parlamentari stabiliscono, oltre all’obbligo di presa in considerazione, che le proposte di legge di iniziativa popolare non decadono con la fine della legislatura, ma possono essere esaminate anche in quella successiva. Il regolamento del Senato, in particolare, prevede che l’esame in commissione inizi entro un mese dal deferimento e contempla la possibilità di audire un rappresentante dei proponenti, designato tra i primi dieci firmatari del progetto.
Sono escluse dall’ambito dell’iniziativa popolare le leggi riconducibili all’iniziativa riservata del Governo, come la legge di bilancio. Gli unici controlli previsti, che vengono effettuati direttamente dalla Camera ricevente, riguardano la regolarità degli adempimenti formali cui le iniziative popolari sono subordinate, in particolare la verifica delle firme apposte in calce al progetto.
A seguito della modifica dell’art. 71 Cost., è stato introdotto il referendum propositivo. In base alla nuova disciplina, una proposta di legge popolare sottoscritta da almeno 500.000 elettori deve essere approvata dal Parlamento entro 18 mesi.
In caso di inadempienza o di approvazione di una legge dal contenuto sostanzialmente diverso da parte delle Camere, i promotori possono chiedere che sia sottoposto a referendum il testo originario proposto dal corpo elettorale. In tal caso, la legge approvata dalle Camere non può essere promulgata fino all’esito negativo della consultazione referendaria. Questa innovazione ha sollevato numerose critiche.
L’iniziativa popolare ha trovato spazio anche negli statuti regionali, dove è prevista non solo per gli atti legislativi, ma anche per i provvedimenti amministrativi. La disciplina statutaria e quella dettata dai regolamenti consiliari hanno cercato di estendere l’operatività dell’istituto, ampliando la platea dei soggetti legittimati — come i Consigli provinciali, un certo numero di Consigli comunali e le organizzazioni sindacali — e di rafforzare le garanzie procedimentali a favore dei proponenti. Tra queste si annoverano agevolazioni per la raccolta e l’autenticazione delle firme necessarie, il diritto di una delegazione di proponenti di partecipare alla discussione sul progetto in seno alla Commissione consiliare competente e la fissazione di termini perentori per l’esame in commissione.
Peculiare è il nuovo statuto della Regione Campania, che prevede un referendum popolare di tipo deliberativo, collegato a un’iniziativa legislativa popolare che, entro un certo termine, non abbia avuto alcun seguito in Consiglio regionale.
Anche per quanto riguarda le iniziative di legge regionale non sono previsti limiti espressi, salvo quelli relativi alle decisioni di bilancio. Diversamente, l’iniziativa diretta all’adozione di provvedimenti amministrativi è soggetta a restrizioni.
In relazione agli atti amministrativi, alcuni statuti provinciali e comunali hanno disciplinato l’iniziativa popolare in modo specifico.
Il referendum: tipologie, disciplina e livelli di esercizio
L’istituto referendario opera a livello nazionale, regionale e locale. A livello statale la Costituzione ne definisce direttamente le tipologie, mentre per il livello regionale l’art. 123, comma 1, Cost. si limita a disporre che “lo statuto regola l’esercizio del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della regione”.
Le tipologie previste a livello nazionale comprendono:
- il referendum abrogativo di leggi;
- il referendum che si inserisce nel procedimento di revisione costituzionale;
- alcune particolari ipotesi referendarie, necessarie per modifiche territoriali di Regioni, Province e Comuni.
Durante i lavori dell’Assemblea Costituente furono proposte anche altre tipologie, come il referendum per dirimere conflitti tra le due Camere su specifici progetti di legge, ma queste ipotesi furono progressivamente abbandonate per la diffidenza verso uno strumento ritenuto estraneo al modello parlamentare e potenzialmente pericoloso per il mantenimento delle scelte operate dagli organi rappresentativi.
Il referendum abrogativo di legge statale
Il referendum abrogativo di legge consiste nella sottoposizione al voto popolare di uno o più quesiti relativi all’abrogazione, totale o parziale, di una legge vigente. L’articolo 75 della Costituzione fissa a 500.000 il numero minimo di elettori necessari per la presentazione della richiesta, ma ammette anche l’iniziativa di almeno cinque Consigli regionali, riconoscendo alle Regioni la possibilità di contrastare leggi statali ritenute ostative allo sviluppo dei principi costituzionali.
Lo stesso articolo stabilisce limiti di materia escludendo le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e indulto, e quelle di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali. Inoltre, prevede un doppio quorum: uno di partecipazione, che richiede il voto della metà più uno degli aventi diritto, e uno relativo all’esito della consultazione, che richiede la maggioranza dei voti validamente espressi.
La Costituzione non individua l’organo incaricato di garantire il rispetto dei limiti, rinviando a una legge successiva: la legge costituzionale n. 1 del 1953 ha affidato tale compito alla Corte costituzionale.
Le richieste di referendum abrogativo non possono essere presentate nell’anno precedente alla scadenza di una delle Camere né nei sei mesi successivi alla convocazione dei comizi elettorali. Esse sono soggette a un primo controllo di conformità da parte dell’Ufficio centrale per il referendum, che verifica non solo il numero e la regolarità delle firme, ma anche la natura dell’atto oggetto della richiesta, che deve essere una legge o un atto avente forza di legge.
L’Ufficio può inoltre unificare richieste referendarie che presentino uniformità o analogia di materia, e può interrompere il procedimento referendario se il Parlamento modifica o abroga le disposizioni oggetto della richiesta.
Nel caso in cui i promotori del referendum ritengano che le decisioni dell’Ufficio centrale abbiano leso ingiustamente gli interessi di cui sono portatori, possono proporre ricorso alla Corte costituzionale mediante conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.
Conclusa la fase di controllo da parte dell’Ufficio centrale la richiesta è sottoposta al giudizio di ammissibilità della Corte costituzionale, che verifica l’assenza di violazioni dei limiti fissati dalla Costituzione all’istituto referendario.
La Corte ha integrato l’elencazione dei limiti previsti dall’articolo 75 della Costituzione, escludendo l’ammissibilità delle richieste referendarie in una serie di ipotesi specifiche. In particolare, non sono ammissibili i quesiti che contengano una pluralità di domande eterogenee, tali da impedire all’elettore di esprimere una volontà chiara.
Sono inoltre escluse le richieste che riguardino norme costituzionali o leggi costituzionali, nonché quelle che incidano sull’applicazione della legge che disciplina il referendum abrogativo.
La Corte ha ritenuto inammissibili anche i quesiti relativi a leggi ordinarie dotate di una particolare forza di resistenza all’abrogazione anche da parte del Parlamento, e quelli che investano leggi ordinarie a contenuto costituzionalmente vincolato, ossia norme il cui contenuto è talmente legato al dettato costituzionale da rappresentare l’unico svolgimento possibile.
Infine, è esclusa l’ammissibilità dei quesiti che mirano all’abrogazione integrale di leggi ordinarie costituzionalmente necessarie.
La Corte ha riconosciuto l’ammissibilità del referendum abrogativo sulle leggi elettorali, a condizione che l’esito non determini una paralisi funzionale dell’organo interessato, conseguenza già ritenuta inammissibile. Ha inoltre ammesso i cosiddetti referendum “manipolativi”, ossia quelli che, attraverso l’effetto abrogativo, mirano a modificare il significato di specifiche disposizioni di legge o di un’intera legge. Tale ammissibilità, tuttavia, incontra un limite: il quesito sottoposto al corpo elettorale non può condurre all’introduzione di una nuova disposizione del tutto estranea al contesto normativo delineato dalla legge oggetto del referendum.
Le fasi del procedimento referendario fin qui esaminate sono regolate da precisi termini temporali. La richiesta deve essere depositata tra il 1° gennaio e il 30 settembre. L’Ufficio centrale per il referendum deve pronunciarsi con ordinanza entro il 15 dicembre, mentre la sentenza della Corte costituzionale deve essere pubblicata entro il 10 febbraio.
Se la richiesta supera positivamente il doppio controllo, spetta al Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri, indire il referendum con proprio decreto, fissandolo in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno. In caso di scioglimento anticipato del Parlamento il procedimento referendario si sospende e i termini riprendono a decorrere dopo un anno dalle elezioni.
Le regole sulla propaganda elettorale si applicano anche alle campagne referendarie.
L’ultima fase del procedimento riguarda lo scrutinio, svolto presso l’Ufficio centrale, e la proclamazione dei risultati. Se l’abrogazione è approvata, il Presidente della Repubblica dichiara l’avvenuta abrogazione con decreto, i cui effetti decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, salvo eventuale proroga di 60 giorni deliberata dal Governo per consentire al Parlamento di colmare il vuoto normativo. Se invece prevalgono i voti contrari, i risultati sono resi pubblici dal Ministro della Giustizia, sempre attraverso la Gazzetta ufficiale. La stessa legge o disposizione non può essere sottoposta nuovamente a referendum abrogativo per un periodo di cinque anni.
Gli effetti del referendum abrogativo sono tali che, in caso di esito positivo, il decreto presidenziale che dichiara l’avvenuta abrogazione totale o parziale della legge sottoposta a consultazione popolare è qualificato tra gli atti aventi valore di legge. La Corte costituzionale ha chiarito che il vincolo derivante dal referendum è giuridico e non solo politico, e che una legge che ripristinasse integralmente la disciplina abrogata sarebbe incostituzionale. Restano però aperti alcuni problemi interpretativi.
In particolare, l’Ufficio centrale ha escluso che il mancato raggiungimento del quorum di partecipazione possa essere considerato equivalente a un voto contrario, e quindi non produce effetti preclusivi. I due quorum previsti dall’art. 75 hanno significati distinti, uno relativo alla costituzione del corpo elettorale, l’altro alla regolare espressione della volontà degli elettori.
Un’ulteriore questione riguarda l’eventuale abrogazione referendaria di una legge che a sua volta aveva abrogato una legge precedente. Secondo alcuni ciò dovrebbe comportare la reviviscenza della norma originaria relativa alla stessa materia. La Corte costituzionale ha invece escluso questa possibilità ritenendo che il referendum, in quanto strumento di legislazione negativa, non possa trasformarsi in strumento di legislazione surrettiziamente propositivo.