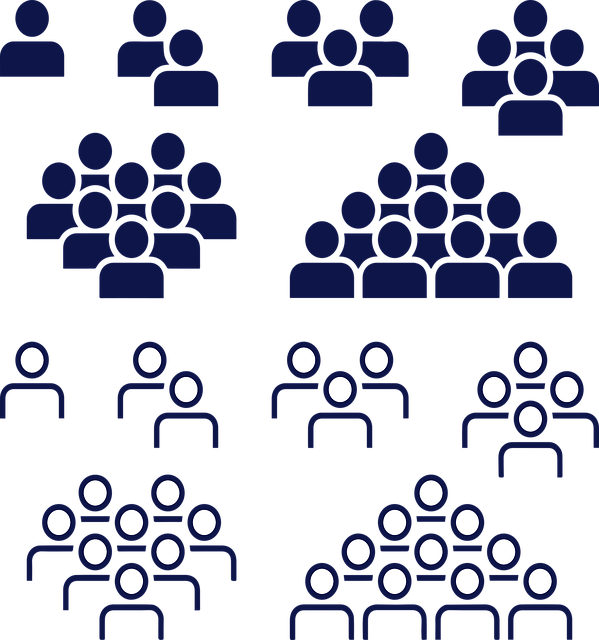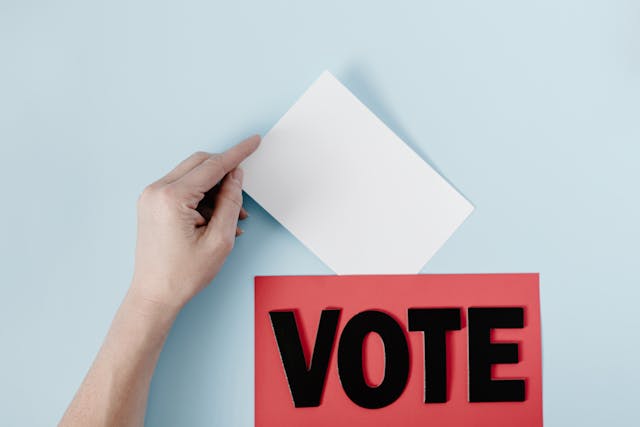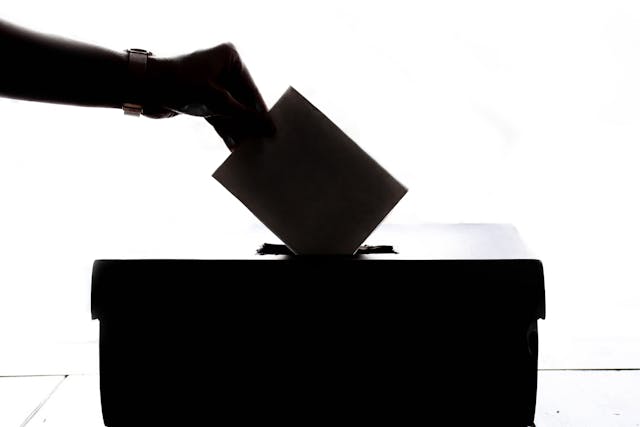La mora del debitore
La mora del debitore, o “mora debendi“, si distingue dal semplice ritardo o “inadempimento relativo” e si verifica quando concorrono tre presupposti:
- il ritardo nell’adempimento dell’obbligazione;
- l’imputabilità di detto ritardo al debitore;
- l’intimazione (o richiesta) per iscritto da parte del creditore al debitore, di adempiere, seppure tardivamente: c.d. mora ex persona.
Peraltro, il presupposto dell’intimazione per iscritto non è necessario e, quindi, la mora si verifica automaticamente al solo verificarsi del ritardo imputabile al debitore (c.d. mora ex re), quando:
- l’obbligazione deriva da fatto illecito (art. 1219, comma 2, n. 1, c.c.): in tali circostanze è fondamentale eliminare prontamente e completamente le conseguenze dell’ingiusta lesione causata dall’illecito;
- il debitore dichiara per iscritto di non voler adempiere (art. 1219, comma 2, n. 2, c.c.);
- l’obbligazione è liquida, a termine e la prestazione deve avvenire presso il domicilio del creditore (c.d. obbligazioni portables)(art. 1219, comma 2, n. 3, c.c.);
- l’obbligazione nasce da un contratto di subfornitura (art. 3, comma 3, L. 18 giugno 1998, n. 192);
- l’obbligazione, pecuniaria, nasce, a titolo di corrispettivo, da una transazione commerciale (art. 4, comma 1, D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231).
Nel caso in cui non sia stabilito un termine per l’adempimento, o quando, pur essendo fissato un termine, l’obbligazione sia quérable, ossia il creditore deve recarsi presso il domicilio del debitore o altrove per ottenere la prestazione, la mora del debitore non è automatica. Il legislatore ritiene che il ritardo possa derivare dalla tolleranza del creditore, pertanto la mora si verifica solo quando quest’ultimo intima l’adempimento per iscritto, senza necessità di formule solenni, configurando la c.d. mora ex persona (Cass. 14 giugno 2018, n. 15714).
Va notato che il principio “in illiquidis non fit mora” non è applicabile nel nostro ordinamento (v. Cass. 30 aprile 2014, n. 9510), quindi la mora può verificarsi anche quando il debito non sia stato ancora oggetto di liquidazione.
Inoltre, la costituzione in mora ex persona vale ad interrompere la prescrizione (art. 2943, comma 4, c.c.; v. Cass. 14 giugno 2018, n. 15714).
La mora debendi può venire in considerazione esclusivamente alle obbligazioni positive. Se l’obbligazione ha natura negativa, ossia consiste in un non facere, basta che il debitore contravvenga all’obbligo assunto, perché si verifichi un inadempimento assoluto, senza possibilità di configurare un ritardo (art. 1222 c.c.).
Effetti del ritardo ed effetti della mora debendi
Il semplice ritardo nell’adempimento di un’obbligazione, pur non configurando la mora del debitore, può comunque avere conseguenze giuridiche rilevanti. Il creditore potrebbe chiedere il risarcimento del danno, la risoluzione per inadempimento, ottenere una sentenza costitutiva ai sensi dell’art. 2932 c.c. che produca gli effetti del contratto non concluso, ecc.
Gli effetti specifici della mora del debitore includono invece:
- l’obbligo di pagare gli interessi moratori sulle somme dovute (art. 1224, comma 1, c.c.) e
- la cosiddetta “perpetuatio obligationis“, ovvero il passaggio del rischio (art. 1221 c.c.). Se il debitore non è in mora, il rischio di un evento fortuito grava sul creditore; cioè, nel caso in cui la prestazione diventi impossibile per causa non imputabile al debitore, l’obbligazione si estingue. Se, invece, il debitore è in mora, il rischio passa a suo carico. In tal caso, se, per causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile, egli, siccome è in mora, non è liberato, ma è obbligato al risarcimento del danno, come se fosse responsabile della sopravvenuta impossibilità della prestazione. La giustificazione risiede nel presupposto che, se la prestazione fosse stata eseguita tempestivamente, il creditore ne avrebbe tratto l’utilità attesa, e il ritardo ha quindi determinato il pregiudizio. Questo principio si basa sull’idea che, se la prestazione fosse stata eseguita tempestivamente, il creditore ne avrebbe tratto l’utilità che si proponeva, e che, quindi, il ritardo ha causato il pregiudizio. Il debitore può liberarsi da questa responsabilità solo se dimostra, con una prova particolarmente complessa, che l’oggetto della prestazione sarebbe comunque perito presso il creditore (art. 1221, comma 1, c.c.). Tale prova non è concessa nel caso di sottrazione illecita della cosa (art. 1221, comma 2, c.c.).
Ulteriori effetti della mora del debitore sono disciplinati in diversi articoli del codice civile.
Differenza di effetti tra mora debendi e mora credendi
La mora del creditore, o “mora credendi“, si verifica quando il ritardo nell’esecuzione della prestazione dipende dal comportamento del creditore anziché da quello del debitore.
In tale situazione, poiché è il creditore che non rende possibile l’adempimento, il debitore non subisce le conseguenze negative che deriverebbero da un inadempimento a lui imputabile.
Anzi, egli non è più tenuto a corrispondere interessi o frutti della cosa, se non per la parte effettivamente percepita (art. 1207, comma 1, c.c.), e potrà pretendere il risarcimento dei danni derivanti dalla condotta del creditore, oltre al rimborso delle spese sostenute per la custodia e la conservazione della cosa dovuta (art. 1207, comma 2, c.c.).
Inoltre, è a carico del creditore in mora il rischio che la prestazione dovuta divenga impossibile per causa non imputabile al debitore (art. 1207, comma 1, c.c.): il debitore viene liberato dalla propria obbligazione, come previsto per ogni ipotesi di impossibilità oggettiva della prestazione (art. 1256, comma 1, c.c.), ma il creditore, se il credito deriva da un contratto a prestazioni corrispettive, non può avvalersi dell’art. 1463 c.c. e considerarsi, a sua volta, liberato dall’obbligo di eseguire la controprestazione, ma dovrà egualmente adempierla.